RIONE CAVALLEGGERI AOSTA
Area di passaggio e di frontiera in cui si respira la
storia dei Lancieri Aosta e delle Fabbriche Napoletane
Incastrato tra
Bagnoli e Fuorigrotta troviamo il rione Cavalleggeri d’Aosta, un popoloso quartiere
di Napoli come i vicini Pianura e Soccavo.
Geograficamente appartengono
ai Campi Flegrei e storicamente sono da sempre integrati nella Diocesi di
Pozzuoli.
Il Rione Cavalleggeri
si sviluppa all’interno di un triangolo i cui vertici sono costituiti dalla
Chiesa di S. Maria Solitaria in via Diocleziano, dalla chiesa dei Sacri Cuori
di Gesù e Maria a piazza Neghelli e dalla chiesa di S. Ciro in via Carnaro.
Il fulcro del rione è
nelle traverse e sullo stesso omonimo viale; ottocento metri di trafficato
asfalto che attraversava un area di passaggio e di frontiera, tra zone
industriali, quartieri operai e quartieri militari.
Nei primi anni trenta
del novecento in vicinanza del Tiro a Segno di Campegna e della Piazza d’Armi
di Coroglio, su di una superficie di oltre 115.000 mq, è realizzata la caserma di cavalleria intitolata al Conte
di Torino. Trattasi di Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino per
nomina dello zio re d’Italia Umberto I° e comandante della Cavalleria Italiana nella
Prima Guerra Mondiale.
Con la riforma del
Regio Esercito si sta provvedendo alla nuova dislocazione dei Corpi d’Armata e
si ha intenzione d’aggregare un reggimento di cavalleria alla Divisione
acquartierata a Napoli. L’antica caserma della cavallerizza a Chiaia è diroccata
ed è impensabile ripristinarla in una zona ormai centrale, giusta quindi l’idea
di realizzarla in aperta campagna non lontana dal nuovo passante ferroviario e
dalla Piazza d’Armi.
La scelta del
reggimento di cavalleria ricade sul glorioso “6° Lancieri d’Aosta”, fondato il
16 settembre dell’anno 1774 (250 anni questo settembre 2024), che si distingue
in innumerevoli fatti d’arme dalle Guerre Napoleoniche, alle Campagne del
Risorgimento, alla Grande Guerra.
Nel primo dopoguerra
“Aosta” vive le vicende del “ripensamento” della Cavalleria, da molti già
ritenuta anacronistica; pertanto il 20 maggio del 1920 perde la “lancia” come
arma principale ed assume la denominazione di “6° Reggimenti Cavalleggeri di
Aosta”.
Il primo ottobre del
1932 avviene il trasferimento da Ferrara alla nuova caserma di Napoli e
contemporaneamente è battezzato con lo stesso nome del reggimento il nuovo
viale che collega la caserma con l’antica via Regia, oggi via Diocleziano.
Poco più di un anno
dopo, l’otto febbraio del 1934, il reggimento riassume la denominazione
tradizionale di “Lancieri di Aosta”; riprende il fregio dei “lancieri” ma
mantiene invariato l’armamento più moderno dei “cavalleggeri”.
Ma il viale, appena
battezzato, non muta il suo nome; resta come “Cavalleggeri Aosta” tramandando
per sempre un titolo che nella realtà il reggimento di riferimento ha avuto
solo per breve tempo.
Non solo, in breve
tempo il suo toponimo si estende all’intero rione che va formandosi attorno ed
in seguito anche ad una nuova stazione della metropolitana realizzata per
meglio servire questo popoloso agglomerato.
Il reggimento dei
Lancieri è formato da due gruppi (corrispondenti ai battaglioni delle fanterie)
a loro volta composti da tre squadroni (corrispondenti alle compagnie delle
fanterie) montate a cavallo più uno squadrone mitraglieri autocarrati.
Intanto la politica
espansionista del fascismo porta ad incrementare la consistenza del reggimento
e nel 1935 sono costituiti altri due gruppi di mitraglieri; ognuno su tre
squadroni ed uno squadrone comando.
Non potendo essere
ospitati nella caserma “Conte di Torino” il III Gruppo è costituito a Torre
Annunziata ed il IV Gruppo a Baia. In quest’altra località flegrea i lancieri
sono alloggiati nelle palazzine popolari rimaste vuote allorché le maestranze dei
chiusi Cantieri Navali di Baia sono trasferite, unitamente alle Famiglie,
presso i cantieri navali di Castellammare di Stabia.
Il 27 settembre 1935
i circa 500 lancieri del IV Gruppo di Baia, comandati dal maggiore
Travaglianti, si imbarcano per Mogadiscio dove ricevono autocarri Ford e con
questi conquistano Neghelli in Etiopia.
Gli squadroni
rimpatrieranno nella tarda primavera del 1937 e saranno subito disciolti, ma il
reggimento, seppure diviso in Gruppi, parteciperà all’occupazione dell’Albania
e alle offensive in Grecia ed in Africa.
Ma la caserma, ancora
con funzione deposito di reggimento, sarà minata ed in gran parte distrutta dai
tedeschi nel settembre del 1943; i cavalli, scappati nei prati dei dintorni,
forniranno un caldo e sostanzioso pasto a molti sfollati.
Il boom economico del
dopoguerra favorisce il mercato edilizio che si mangia la zona rurale; sparisce
il verde e, al costo d’un alto tasso d’inquinamento, si costruisce a ridosso
della ILVA, della CEMENTIR e della ETERNIT.
La vivibilità è sacrificata
in nome del lavoro che sfama migliaia di famiglie che ben presto formano una comunità
locale peraltro integrata nelle tradizioni partenopee. Come non ricordare due
“grandi” musicisti figli di questo rione; Beppe Vessicchio che vi nasce nel
marzo del 1956 e Gigi D’Alessio qui nato nel febbraio del 1967.
La crisi economica
della metà degli anni '80 decreta la chiusura delle industrie e lo
sgretolamento del tessuto sociale prosperato all’ombra delle ciminiere.
Anche un pezzo della
storica caserma è demolito per accogliere i container che ospitano parte dei
terremotati del 1980. Il campo è sgombrato dopo una decina d’anni e al suo
posto nasce un presidio dei carabinieri ma, purtroppo, la porzione di caserma
ancora in piedi resta abbandonata.
GIUSEPPE PELUSO
Pubblicato su Segni
dei Tempi di settembre 2024
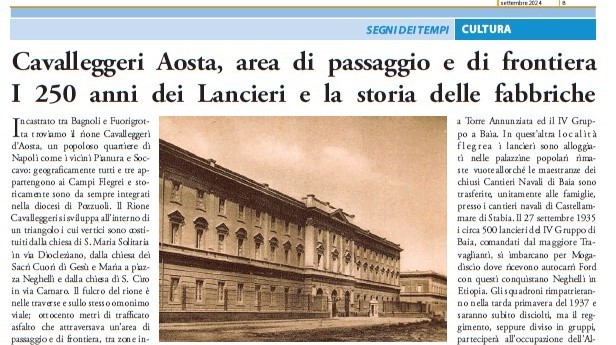



.jpg)































