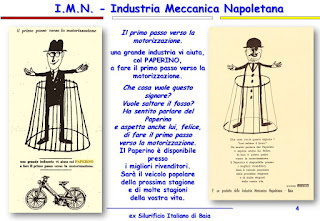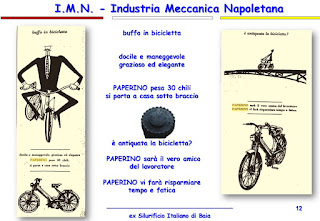I Campi Flegrei non sono unici
Ci sono anche quelli di Calcidica e quelli del Mar di
Sicilia
Nel mentre gli autori antichi chiamano Flegri
tutti i luoghi che buttano fuoco, quelli medioevali concordano nel dire che la
vera Flegra sia situata in Terra di Lavoro. Ovvero in un luogo posto tra
Campana e Quarto, con intorno dei Monti chiamati Leucogei per la loro
bianchezza cagionata dal fuoco e dallo zolfo [1].
Tra i classici Diodoro Siculo [2], storico
greco-siciliota che chiama Flegra anche il Vesuvio, racconta che Ercole partì
dal Tevere e, percorrendo le regioni costiere del paese che per noi ora è
l’Italia, raggiunse la piana di Cuma.
Il mito narra che qui esistevano uomini di
forza superiore chiamati Giganti; famigerati perché non rispettavano alcuna legge.
Tale piana era detta Flegrea, ossia “Ardente”, a causa di un monte che in tempi
remoti aveva eruttato un fuoco immane; oggi codesto monte, continua Diodoro, è
noto col nome di Vesuvio.
Quando i Giganti seppero dell’arrivo di
Ercole si raccolsero tutti assieme e si disposero a battaglia contro di lui; ne
nacque uno scontro poderoso per la forza e l’ardire dei Giganti, in cui si dice
che Ercole, aiutato dagli Dei, alla fine trionfasse eliminandoli quasi tutti.
Polibio, (storico greco antico), continua a
menzionare Timeo di Tauromenio, (storico greco-siciliano) [3], pur avendogli in
precedenza dato dell’ignorante, riportandone una affermazione con la quale
asserisce che tutta la pianura intorno a Capua e Nola si chiamava un tempo
Flegrea. Che essa era stata occupata dagli Etruschi e godeva di grande
reputazione per la sua fertilità.
Ribadisce poi che era chiamata, come
altre, Flegrea con riferimento a Flegra-Pallene in Calcidica [4] dove la
mitologia localizza la lotta tra Zeus e i Giganti.
In questo caso è fuori di dubbio che si debba
connettere la battaglia dei Giganti e lo stesso toponimo Flegra al punto
da indurre a ritenere che i Campi Flegrei siano una sorta di antica
menzione di un'unica leggenda.
Infatti Eudossio (vescovo ariano e Patriarca
di Antiochia) e Teagene (tiranno di Megara in Grecia) chiamano Flegra pure il
Pallene di Tracia; ovvero la penisola dove sorge l’odierna Cassandra, la più
occidentale delle tre penisole della Calcidica nel mare Egeo, che fu coinvolta
nella lotta fra gli Dei e i Giganti.
Pertanto gli Antichi appellano con il nome
Campi Flegrei tutti i luoghi che con tal nome esprimono sia la natura
morfologica dei medesimi, per i fenomeni sulfurei e vulcanici, sia la natura
mitologica degli stessi, quando riportano leggende di guerre di giganti.
Giacomo Martorelli, docente di greco e
studioso delle antichità nel settecento, riconosce di origine Fenicia
l’etmologia del nome Flegra: “mira contentio”, ovvero “meravigliosa contesa” e
per lui la base è simile all’etimo della voce “Pallene”, “pale mirabilis”,
ovvero “portentosa” [5].
Tutto questo rivoluzionerebbe le nostre
certezze circa la derivazione greca di “terre ardenti” e confermerebbe quanto
affermato da Diodoro in merito alle guerre, sia nella Pallene di Tracia che nei
nostri Campi Flegrei, degli Dei contro i giganti invasori di tali fertili
luoghi.
Ma la parola “flegrea”, quale derivazione di
ardente, ha preso il sopravvento ed in tempi più recenti altre zone vulcaniche
hanno di diritto preso possesso di questo appellativo.
I più famosi tra questi sono i “Campi Flegrei
del Mar di Sicilia”, noti anche come “Campi Flegrei del Canale di Sicilia” [6].
Una regione vulcanica sottomarina situata nel
canale di Sicilia tra la costa italiana, da cui dista 20 miglia nautiche in
direzione nord-est, e l'isola di Pantelleria, in direzione sud-ovest; compresa
quindi nelle acque territoriali italiane.
Questa regione vulcanica include una
depressione a 1000 metri
composta da dodici vulcani, tra cui il più famoso è l'Empedocle.
Gli altri vulcani che compongono i “Campi
Flegrei del Mar di Sicilia” sono: “Anfitrite”; “Cimotoe”; “Galatea”; “Madrepore”;
“Banco Nerita”; “Banco di Pantelleria”; “Pinne”; “Banco Smyt I”; “Banco Smyt II”;
“Banco Terribile”; “Tetide”.
La prima eruzione conosciuta dei “Campi
Flegrei del Mar di Sicilia” risale alla prima guerra punica verso il 253 a .C. quando i vulcani “Empedocle”
e “Pinne” diventano attivi. Bisogna poi attendere il 1632 quando una seconda
eruzione è riconosciuta come attività subacquea attribuita ad “Empedocle”.
Dopo un'attività discutibile del 1701
un'altra eruzione di questo vulcano va dal 28 giugno al 11 agosto 1831 quando
dà vita all’isola “Ferdinandea”.
Già dal 22 giugno 1831 sono percepite scosse
lievi a Sciacca, ma poi il 28 si sente un forte sussulto, accompagnato da cupo
boato, e nello stesso giorno due battelli inglesi, navigando tra Sciacca e
Pantelleria, subiscono dei colpi allo scafo, come se avessero urtato qualche
cosa.
Il 2 luglio, sempre a Sciacca, si comincia a
sentire un odore fetido e i pescatori riferiscono d’aver visto, al largo, il
mare ribollire.
Due giorni dopo è raccolta, nello stesso
braccio di mare, una grande quantità di pesci morti o tramortiti.
Il primo a osservare fumo e vapori è il
capitano siciliano Trefiletti che, attirato da una nube e dai rumori, si
avvicina con il suo battello "Gustavo" e vede: «l'acqua del mare sollevarsi per una forza meravigliosa e formare una
colonna sormontata da fumo, per una altezza di circa 18 metri e un diametro di
almeno 30».
I giorni 10 e 11 luglio il principe
Pignatelli, avvicinandosi alla zona con una piccola barca, assiste all'eruzione
di ceneri e pietre, accompagnata da lampi e fuochi di diversa forma e colore,
ma non vede alcuna terra emersa.
La vede invece il 16 luglio Corrao, il comandante
del bastimento napoletano "Teresina", che la valuta alta circa 12 piedi (3,6 metri ) sul livello
del mare.
E’ questa la nuova isola appena emersa che
oggi si usa chiamare “Giulia Ferdinandea” unendo i nomi che le hanno dato il
vulcanologo francese Constant Prevost e il vulcanologo napoletano Carlo
Gemmellaro [7].
Ma l'isola è battezzata in vari modi dai suoi
scopritori e "pretendenti" poiché si ritrova al centro di una
travagliata disputa territoriale tra la Gran Bretagna, la Francia ed il Regno delle
Due Sicilie.
Il 12 agosto corre sul posto il vulcanologo Gemmellaro,
suddito del re delle Due Sicilie, che non riesce a sbarcare a causa delle
eruzioni in atto. Comunque fornisce una descrizione dettagliata ed i primi
disegni dell’isola che ha raggiunto tre miglia di perimetro ed una altezza di
circa 60 metri.
Inizialmente l’isola è chiamata “Graham” dal
capitano Jenhouse che vi giunge il 2 agosto 1831 e il 24 ne prende formalmente
possesso in nome di Sua Maestà Britannica, piantandovi la bandiera inglese [8].
Il 26 settembre, per contrastare l’azione
inglese, arriva in vista della nuova isola il geologo Constant Prevost, inviato
dalla Francia a bordo della "Flèche", che la chiama “Giulia”
(Juillet) perché nata nel mese di luglio.
Come gli inglesi, anche i francesi approdano
sull'isola senza chiedere alcun permesso a re Ferdinando II di Borbone
nonostante l'isola sia sorta entro acque prossime alle coste siciliane. Anzi i
francesi pongono una targa con la seguente iscrizione: "Isola Iulia – i sigg. Constant Prévost, professore di geologia
all'Università di Parigi – Edmond Joinville, pittore - 27, 28, 29 settembre
1831".
In segno di possesso viene innalzata sul
punto più alto la bandiera francese.
Praticamente l'isola avrebbe goduto,
all'epoca, dello stato di “insula in
mari nata”; cioè, in quanto emersa dal mare, la prima nazione o persona
a mettervi piede avrebbe potuto rivendicarla legittimamente, in questo caso gli
Inglesi.
Il fatto che fosse in acque territoriali
siciliane però complica la situazione e questi avvenimenti fanno montare una
protesta degli abitanti del Regno delle
Due Sicilie che, assieme a quelle del capitano Corrao, arrivano anche
alla casa borbonica. Si propone di nominare l'isola con nome italiano e si chiedono
al re provvedimenti contro il sopruso inglese.
Il re Ferdinando
II, constatato l'interesse internazionale che l'isoletta ha suscitato,
invia sul posto la corvetta “Etna” al comando dello stesso capitano Corrao il
quale, sceso sull'isola, pianta la bandiera borbonica battezzando l'isola
"Ferdinandea" in onore del suo sovrano.
Dalla fine dell'eruzione l'isola è soggetta a
crolli ed sprofondamenti. Il 7 novembre si nota solo una grande e bassa
spiaggia sulla quale si erge una collina alta 20 metri; a dicembre non si vede
altro che il frangere delle onde su un basso fondale ed a gennaio 1832 si
notano dei picchi solo a due metri di profondità.
A questo punto la storia dell’isola è
conclusa; essa, formata da scorie e lapilli, è stata demolita dal moto ondoso e
probabilmente anche abbassata da un collasso della camera magmatica. Resta una
estesa secca, nota come ”Banco di Graham” (nome adottato dalla Royal
Geographical Society di Londra riprendendo quello scelto dal capitano Denhouse),
il cui punto più alto si trova ad otto metri dalla superficie [9].
Nel 1846, il 12 agosto 1863, nel 1867 e forse anche il 30 settembre
1911, l'isoletta riappare ancora in superficie, per poi scomparire
nuovamente dopo pochi giorni. Di essa restano solo i molti nomi avuti in
seguito alla disputa internazionale: “Julie”, “Nerita”, “Corrao”, “Hotham”, “Graham”,
“Sciacca”, “Ferdinandea”; troppi per una piccola isola spuntata di colpo dal
mare e rimasta visibile appena quattro mesi.
Ciò che avvenne in quella lontana estate
altro non era che un fenomeno legato al diffuso vulcanesimo di questo tratto di
mare. Oltre alle due isole completamente vulcaniche di Pantelleria e Linosa, in
questo settore del Mediterraneo, ci sono infatti altri diversi apparati
vulcanici sommersi che sono stati attivi in tempi geologici recenti. Per questi
motivi questo tratto di mare è stato addirittura chiamato "Campi Flegrei
del Mar di Sicilia", a indicarne l'intensa attività vulcanica e
post-vulcanica con frequenti emissioni fumaroliche e termali; così come avviene
nei nostri Campi Flegrei.
A scanso di equivoci, e visto probabili
segnali premonitori di una riemersione dell’isola, i siciliani hanno posto
sulla superficie del banco sottomarino una targa in pietra, sulla quale si
legge:
«Questo lembo di terra una volta isola Ferdinandea era e sarà
sempre del popolo siciliano.»
BIBLIOGRAFIA
AA.VV -
Memorie Di Matematica E Fisica – 1799
AA.VV – Isola Ferdinandea – Wikipedia -
Paolo
Colantoni –C’era una volta un’isola – luglio 1982
Paolo
Colantoni – Rischio vulcanico - ENI – settembre 2011